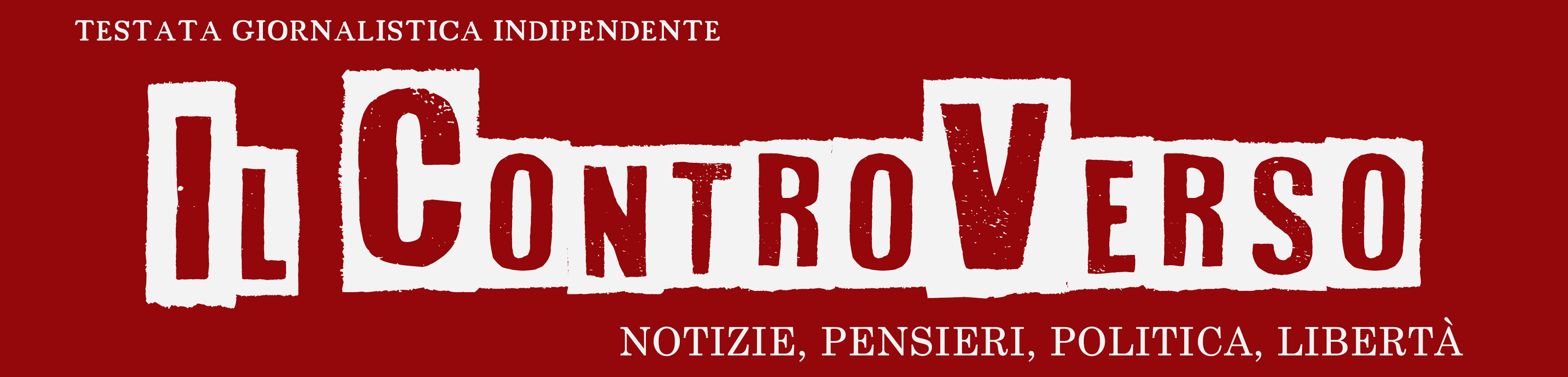Tutti si appellano alla pace, credenti e non credenti, sinistra e destra, una pace che tanto più è conclamata quanto più la violenza appare l’unico reale fattore prospettico di lavoro per l’uno o per l’altro degli elementi in contesa. Così ogni uomo che è condotto da una volontà di pace non riesce ad evitare una diffidenza che rovina ogni aspetto di sicurezza.
Viviamo in un’epoca che sembra descritta dalla frase biblica: “Io sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra” (Salmo 119).
Ma la coscienza dell’uomo può aprirsi a una possibilità di pace almeno in un punto: l’affermazione chiara e certa di un senso della vita umana. Questa è la potenza esortativa della parola pace: essa può dare rilievo al sentimento umano di tutta la vita stessa; chi la grida, la sente motivo ultimo dei fattori determinanti la sua vita sociale, familiare e personale.
Il significato della parola pace impegna sempre la totalità dei sentimenti della vita; li implica secondo una giustizia che è tale di fronte al destino, minuscolo o maiuscolo.
Se c’è una parola atta a delineare questo “pondus” che ha il sentimento umano della pace, è la religiosità, la religiosità come dimensione umana della vita. Essa investe qualsiasi formula, implicando un ultimo scopo per cui un uomo accetta di esistere e agisce.
Ciò per cui sentiamo necessario vivere rapporti di ogni genere, infatti, è il presentimento di una positività ultima. Il giudizio che dà sulla vita di ogni giorno questo presentimento – che, come tale, è in tutti più spesso che no – può essere anche frutto di quel cinismo che nella nostra società abbonda.
Così, collocare la divinità – o, in altri termini, il supremo scopo dell’agire – nella potenza politica, potrà illudere le persone più impegnate, più pensose, circa la possibilità di realizzare quella che gli antichi chiamavano “pax romana”: una generica tolleranza verso tutti, salvo l’ultima parola che si riservava il potere politico, per cui era permessa un’attenzione a qualsiasi Dio, purché non deprimesse la divinità dell’imperatore – e che nei nostri tempi si potrebbe chiamare “pax americana” o pace sociale.
È più difficile trovare un uso vero della parola pace nelle grandi trame politiche ed economiche che non nel rapporto familiare o nel groviglio di tendenze desiderose di adempimenti o di sazietà personali, cioè nel cuore dell’uomo.
La pace, allora, può essere sentita e vissuta e pensata solo a due condizioni: la vocazione, cioè la dipendenza da un Altro come disegno e giudizio sulla propria vita – come per la prima volta è emerso nella storia del popolo ebraico – e l’educazione alla conoscenza del bene e del male.
Perciò la pace dipende dal fatto che l’uomo ammetta l’impossibilità di darsi la perfezione da sé stesso, mentre indomabilmente riconosce il suo debito verso l’Essere.