Ahmadreza Djalali è un medico. Nato in Iran nel 1971, ha vissuto in una famiglia del ceto medio. Studente talentuoso, laureatosi in medicina dopo sette anni, si è sposato nel 1999 e da quell’anno ha lavorato per il Ministero della Salute (centro gestione crisi) e per il Ministero della Difesa. Come lui stesso dichiara:
«Facevo parte di uno dei più importanti progetti del paese. Era il periodo fra il 2001 e il 2003. Dopo aver lasciato il Ministero della Difesa ho lavorato in uno degli istituti per la ricerca scientifica del paese per quattro o cinque anni […] poi ho deciso di andare all’estero per continuare gli studi e lì studiavo e lavoravo insieme ma c’erano dei progetti in Iran […] e cooperavo anche con loro».
Dopo il dottorato, quindi, studia e lavora all’estero e fra i vari incarichi collabora con l’Università del Piemonte Orientale: CRIMEDIM- research center in Emergency and Disaster Medicine.
Fin qui si può dire che la storia del medico iraniano sia simile alla biografia di molti uomini, distinguendosi al più per i grandi meriti accademici e umanitari.
Questo è tutto ciò che dovrebbe contare nella sua storia, ma purtroppo la vita del giovane medico (e quella della sua famiglia) ha subito un grosso cambiamento nel 2016, quando nel dicembre di quell’anno il governo iraniano ha fatto su di lui delle grandi pressioni, affinché confessasse di essere una spia per conto dell’Unione Europea. Al suo rifiuto, è stato accusato di moharebeh, ovvero un delitto previsto dalla Sharia iraniana considerato un’offesa contro l’Islam. È stato inoltre accusato di aver fornito notizie sui programmi militari e nucleari iraniani al Mossad.
«Ahmadreza Djalali è stato condannato a morte al termine di un processo profondamente irregolare che mette in evidenza non solo l’ostinazione delle autorità iraniane per l’uso della pena di morte, ma anche il loro enorme disprezzo per lo stato di diritto».
Queste le parole di Philip Luther, direttore delle ricerche sul Medio Oriente e sull’Africa del Nord di Amnesty International, nel 2017.
Catapultato in una situazione umanamente inaccettabile, Ahmadreza Djalali ha protestato contro l’illegale detenzione, cominciando uno sciopero della fame nel 2017. Questa è una forma di protesta adoperata da molti fra quelli cui è stata negata la libertà di espressione, parola e difesa. Fra quelli a cui, in poche parole, è stato negato il diritto alla dignità della vita. Da quel momento il Dottor Djalali ha perso venti chili e avuto due collassi.
In seguito all’arresto, non ha potuto mettersi in contatto con la famiglia per dieci giorni, dopo averne trascorsi sette nella Sezione 209 della prigione di Evin, un luogo tristemente noto nel quale vengono tendenzialmente rinchiusi i prigionieri politici.
In base alle testimonianze di chi vi è stato detenuto, vi sarebbero solo celle individuali, di circa 1 metro per 1,80 cm, portando così i prigionieri a uno stato di totale isolamento dal mondo. Un neon, inoltre, proietta luce nella cella per ventiquattro ore su ventiquattro applicando la cosiddetta “tortura bianca” e portando la persona che la subisce a crollare quando avvengono gli interrogatori, sotto molti aspetti definibili come torture.
Ahmadreza Djalali è stato spesso portato in quella sezione del carcere nel corso degli ultimi anni e, spinto dalle condizioni inumane nelle quali era tenuto, ha infine fornito (come molti altri) delle confessioni forzate, necessarie al governo iraniano, che non aveva effettivamente prove a carico del medico.
Il caso del dottore sembra rientrare nel più ampio schema d’incriminazione sulla base di capi d’accusa falsi, o comunque privi di prove, relativi a cause di scurezza nazionale contro persone con doppia cittadinanza e legami con l’estero, come ad esempio nel caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe (project manager iraniano-britannica della Thomson Reuters Foundation), di Jason Rezaian (giornalista iraniano-americano del Washington Post) e della docente universitaria canadese-iraniana Homa Hoodfar.
Nel 2017, poco dopo l’arresto del dottore, la moglie Vida Mehrannia Djalali ha dichiarato:
«Ancora oggi i bambini non sanno esattamente cosa sta succedendo. Loro piangono e chiedono: dov’è il nostro papà? Mi distrugge l’idea di non dargli una risposta. Ogni mattina mio figlio mi chiede dove sia il padre, ogni giorno. Tante volte vede qualcuno di spalle e crede che sia suo padre. […] Per il primo mese la nostra unica telefonata è durata un minuto. Sono diciannove mesi che non vediamo Ahmadreza. Non sapevo come fare, avevo paura di me stessa e di quello che potevo fare. Sono finita in ospedale… poi ho realizzato di avere due bambini e che dovevo continuare ad andare avanti a vivere».

Sempre nel 2017 il procuratore di Teheran ha associato, senza alcuna prova, il Dottor Djalali agli omicidi del 2010 dei Dottori Massoud Ali-Mohammadi e Majid Shahriari (docenti esperti di nucleare) e, nel dicembre dello stesso anno, la Prima sezione della Corte Suprema ha confermato la condanna a morte di Ahmadreza, senza prima presentare istanza o consentire la preparazione e presentazione di documenti di difesa, nonostante la legge iraniana lo preveda.
Nel 2018, la Sezione 33 della Corte Suprema ha respinto, inoltre, la richiesta di revisione della condanna a morte e ha successivamente arrestato l’avvocatessa Zenyab Taheri, la quale si occupava, fra gli altri, del caso di Djalali. Nel 2019 il medico è stato trasferito, bendato, senza che se ne sappia il motivo, in un luogo sconosciuto. Nel novembre 2020 è stata ribadita la sua condanna a morte ed è stato trasportato nuovamente in isolamento.
Gli sforzi atti a liberare, o quantomeno ad avere un processo per Ahmadreza Djalali, sono finora stati non pochi, ma vani.
Nel 2017 Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia (associazione fra quelle che più si stanno occupando del caso e sul cui sito web è possibile firmare la petizione per la vita del Dottor Djalali), ha consegnato 3000 firme, in aggiunta alle precedenti 3500, all’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran. Tutto ciò in un incontro al quale presenziavano anche i senatori Elena Ferrara e Luigi Manconi e nel quale hanno presentato il “Testo dell’Interpellanza” al Ministro degli Esteri del periodo, Angelino Alfano. Nel 2018 la Svezia ha conferito la cittadinanza ad Ahmadreza Djalali e in quello stesso anno 121 premi Nobel hanno chiesto un equo processo alla Guida Suprema dell’Iran (Ali Khamenei) per poi ripetere la richiesta l’anno successivo.
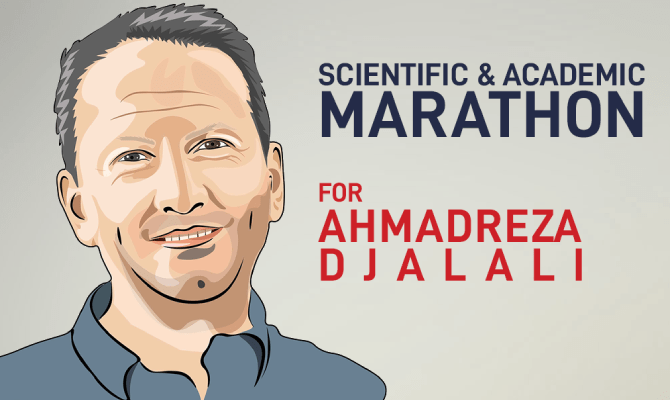
Vida Mehrannia Djalali è stata da subito una delle più importanti combattenti per la vita del marito. Donna di grande coraggio e forza d’animo, si è da subito attivata per consentire ad Ahmadreza di sopravvivere.
Dal momento del suo arresto, la donna ha cominciato una grandissima campagna di informazione sulla situazione del marito, visitando molti paesi e tre università europee nelle quali il medico aveva lavorato. Nel 2019 ha incontrato Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, descrivendogli la situazione e le condizioni mediche dell’uomo che, come già accennato, ha a lungo lavorato in Italia. Ha inoltre effettuato un appello, affinché il governo italiano potesse intraprendere un’azione decisiva in aiuto del medico.
Nonostante le sollecitazioni e l’impegno di attivisti, associazioni e avvocati per i diritti umani, Ahmadreza Djalali è ancora immerso nello stesso incubo da più di tre anni e sarebbe necessario un reale impegno da parte delle istituzioni che ancora non si sono esposte per salvargli la vita, una vita che è in se stessa importante e che ha, come tutte le altre, diritto ad essere pienamente vissuta.




