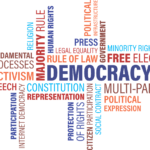«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»

«La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni».
Giovanni Falcone
Sono trascorsi ventotto anni dal 23 maggio 1992, quando il magistrato antimafia Giovanni Falcone cadde vittima di un attentato di stampo terroristico-mafioso, perpetrato a Capaci da Cosa Nostra. Alle ore 17.57 di quel pomeriggio gli attentatori fecero esplodere un intero tratto dell’autostrada A29, che collega Palermo all’aeroporto di Punta Raisi, mentre transitava il corteo di vetture blindate su cui viaggiavano il giudice, la moglie e gli agenti della scorta. Insieme a Falcone morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anch’ella magistrato, e gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Altre ventitré persone rimasero ferite, fra di esse gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza.
«L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza».
Giovanni Falcone
Fin da subito è emersa la volontà di smuovere le coscienza collettiva, di cambiare le cose; di anno in anno, la speranza di educare i giovani, non solo di Palermo, ma dell’intero Paese, ai valori della legalità e della libertà non è rimasta utopia, ma si è tramutata in realtà. Intorno a questi simboli, a queste personalità di straordinaria integrità e dedizione allo Stato, si rinsalda sempre più il senso di unità nazionale, non scontato neppure in una Repubblica fondata sulla democrazia e sulla libertà del suo popolo. Sebbene in quello sciagurato 1992 le istituzioni repubblicane abbiano vacillato sotto gli attacchi diretti e spietati di Cosa Nostra, il sacrificio dei magistrati e appartenenti alle Forze dell’ordine, e di tutte le vittime innocenti di mafia, non è andato perduto. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati servitori eccezionali per lealtà e professionalità, combattenti coraggiosi e sapienti per la causa della legalità, sempre in difesa della libertà e dei diritti dei cittadini.
Come ha rimarcato la sorella Maria in un’intervista rilasciata di recente alla Rai, Giovanni Falcone ha vissuto gli ultimi dodici anni della sua esistenza in lockdown. Un confino non voluto, ma subìto. Un magistrato che, per aver aggiornato gli strumenti di contrasto del fenomeno mafioso, è stato ripagato con una campagna diffamatoria che solo la scomparsa prematura e violenta ha interrotto. È stato emarginato, depotenziandolo, un uomo che ha messo a disposizione dello Stato non solo la propria preparazione professionale, ma anche la propria determinazione nel portare a termine ad ogni costo il proprio lavoro. Alla domanda su cosa lo spingesse a insistere nel suo operato, aveva risposto: «per spirito di servizio». Una testimonianza di dignità e senso del dovere, mistificata dai detrattori come smania di protagonismo nel lavoro, delicato quanto scomodo, volto a districare la matassa di un sistema così scottante quale quello mafioso.
Esempi morali per le giovani generazioni: di passione civica, senso delle istituzioni, di abnegazione e spirito di sacrificio, fino all’estremo, nella lotta contro le forze del crimine, della violenza, dell’anti-Stato.
Se non vi fosse stato il maxiprocesso contro la mafia – istruito dal pool di Falcone e Borsellino e celebrato dinanzi alla Corte d’Assise, presieduta da Alfonso Giordano con Pietro Grasso giudice a latere – la condizione della Sicilia e dell’Italia non sarebbe stata quella di oggi. I preziosi frutti del loro impegno sono stati raccolti nel solco della strada da loro tracciata. Se il maxiprocesso e la sentenza che lo concluse, nel dicembre del 1987, segnarono una svolta decisiva nella lotta contro la mafia, essenziali furono i provvedimenti di legge che seguirono, anche su impulso della Commissione parlamentare antimafia e in risposta a una offensiva sanguinosa che sarebbe culminata, appunto, nell’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo stesso Falcone era stato il principale ispiratore, da Direttore degli Affari Penali del Ministero della Giustizia, di quei provvedimenti, tra i quali la legge sui “pentiti” e nuove norme di sistema, sul piano processuale e penitenziario, capaci di meglio contrastare la criminalità organizzata, fino alla istituzione della Direzione Investigativa Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia. Tutto ciò va ricordato, insieme con il tragico sacrificio della vita di quegli autentici eroi di quella causa della legalità, della convivenza civile, della difesa dello stato democratico, con la quale si erano identificati; e insieme come costruttori di un più valido presidio giuridico e istituzionale di fronte alle sfide della criminalità organizzata. Le amarezze, che Giovanni Falcone purtroppo conobbe, non gli impedirono di fare fino in fondo la sua parte, lasciandoci in eredità strumenti preziosi da rafforzare e aggiornare via via e da impiegare con determinazione e coerenza.

Per sconfiggere la mafia e la criminalità in Sicilia, nel Mezzogiorno e in tutta Italia, conta la qualità della politica, il prestigio delle istituzioni democratiche, l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, conta, in modo fondamentale, la crescita della coscienza civica e della fiducia nello stato di diritto: fiducia che costituisce un vero e proprio “capitale sociale” e che può rafforzarsi solo in un clima di rispetto, in ogni circostanza, degli equilibri costituzionali da parte di tutti coloro che sono chiamati ad osservarli. Ogni intervento capace di incidere sul divario tra Nord e Sud, sull’arretratezza, per molteplici aspetti, delle condizioni del Mezzogiorno, sulla carenza di prospettive di occupazione qualificata.
La politica e la giustizia non possono e non debbono percepirsi come “mondi ostili guidati dal reciproco sospetto”; deve prevalere in tutti il senso della misura, del rispetto e, infine, della comune responsabilità istituzionale, nella consapevolezza di essere chiamati solidalmente a prestare un servizio efficiente, a garantire un diritto fondamentale ai cittadini.
Quella del magistrato è una funzione che esige equilibrio, serenità e sobrietà di comportamenti. Il suo unico fine è quello di applicare e far rispettare le leggi attraverso un esercizio della giurisdizione che coniughi il rigore con la scrupolosa osservanza delle garanzie previste per i cittadini. Tale ruolo non deve cedere a “esposizioni mediatiche” o al sentirsi investiti di missioni improprie ed esorbitanti oppure a indulgere ad atteggiamenti impropriamente protagonistici e personalistici, che possono offuscare e mettere in discussione la imparzialità dei singoli magistrati, dell’ufficio giudiziario cui appartengono, della magistratura in generale. D’altronde è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 224/2009 a ricordare che “i magistrati, per dettato costituzionale devono essere imparziali ed indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento”.
Riprendendo le parole con le quali, il giudice Guido Galli, ucciso dai terroristi di Prima Linea, il 19 marzo 1980, spiegò al padre la sua scelta di entrare in magistratura: «perché vedi, papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti e alle “belle sentenze” o ai libri; io ho pensato soprattutto a un mestiere che potesse darmi la grande soddisfazione di fare qualcosa per gli altri». La carica umana di Guido Galli e la sua sollecitudine per i problemi della società hanno caratterizzato le condotte di tanti magistrati, tra i quali, non pochi, barbaramente uccisi solo per aver fatto il loro dovere.
Da ultimo, la manipolazione giornalistica, che offre una visione distorta dei fatti per assecondare movimenti di opinione che negano il garantismo e finisce per vanificare la presa culturale sulla società del sacrificio – non voluto né cercato – di quei magistrati animati da uno spirito di servizio che trascende la pur legittima ambizione professionale. Interessanti riflessioni sul tema, sono state fatte dal Professore Giovanni Fiandaca, Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, sulla rivista giuridica “Sistema Penale”, ove ha appunto pubblicato un articolo dal titolo: “Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica”.
Scrive Fiandaca: «L’ossessione securitaria incentrata sulla pericolosità comunque persistente del mafioso (salvo che egli rompa il vincolo associativo nell’unico modo che l’antimafia ‘purista’ considera credibile, cioè con la collaborazione giudiziaria), a ben vedere, concepisce la mafiosità come qualcosa di simile a una categoria antropologica, tale per cui il mafioso assurgerebbe ad un tipo astratto di autore destinato, per le sue (presunte) caratteristiche intrinseche, a incarnarsi senza eccezione (come per effetto di una infallibile legge di natura!) in tutti i mafiosi in carne e ossa». Ed inoltre: «Le tendenze populiste, che da qualche tempo orientano e inaspriscono la politica penale (peraltro, non solo nel nostro paese), sfruttano e canalizzano politicamente pulsioni punitive connesse a sentimenti di paura, frustrazione, rabbia e risentimento diffusi a maggior ragione in periodi di crisi economica soprattutto nei ceti più svantaggiati od emarginati: da qui un uso politico dello strumento penale come arma puntata contro nemici sociali di turno (criminali organizzati, corrotti ecc.) elevati a capri espiatori. Si instaura di conseguenza un circolo vizioso, nel senso che il populismo penale rilancia e rafforza istanze punitive preesistenti in seno alla società.» «Ma è pur vero che non tutta l’antimafia giudiziaria mostra, oggi, di essere incondizionatamente a favore di un uso massiccio della pena carceraria. Al suo interno è dato registrare qualche voce più pensosa e critica, come ad esempio quella di Roberto Scarpinato – magistrato antimafia tra i più conosciuti – il quale ha, di recente, scritto: “La questione-carcere resta la cattiva coscienza di questo Paese e la cartina di tornasole delle storture di un sistema di giustizia che, per un verso, declama nobili principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di trattamento rieducativo dei condannati, e, per altro verso, continua a ospitare nelle carceri la stessa popolazione carceraria degli inizi del Novecento (…) oggi, come ieri come l’altro ieri, in carcere a espiare la pena finisce quasi esclusivamente chi occupa i piani più bassi della piramide sociale”.»
La Costituzione italiana all’art. 27 recita : “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte“.
La Carta costituzionale, con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario n° 354/75 e con il successivo intervento del 2007, è stata modificata introducendo alcuni aspetti di umanizzazione del trattamento penitenziario quali: permessi, licenze ed ulteriori agevolazioni; in particolar modo, è stata abrogata la pena di morte, la quale solo in 101 stati è stata eliminata completamente. Tuttavia vi sono casi di Paesi nel mondo che eseguono sporadicamente o sistematicamente esecuzioni in maniera extra-giudiziale, al di fuori quindi della loro stessa struttura giuridica. Solo al 2014, infatti, risale l’ultima condanna in Sudan.
Il nostro legislatore con l’espressione normativa “le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato” inserita al comma 4 dell’Art. 27 Cost., vuole intendere che la rieducazione è la finalità ideologica della pena e consiste nel creare da parte dello Stato durante l’esecuzione della stessa, le condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso mettendolo poi in condizioni, una volta in libertà, di non commettere nuovi reati. Tale finalità fu introdotta proprio per salvaguardare la dignità umana quale diritto fondamentale dell’uomo in quanto tale; ma ci si chiede, lecitamente, se sia davvero così, se il nostro sistema penitenziario miri e garantisca davvero quanto la costituzione statuisce.
Lo stato sociale di diritto, come ampiamente sostenuto da Illustri penalisti, quali il Prof. Claus Roxin, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Ludwig Maximilian”di Monaco e il Prof. Sergio Moccia, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, deve fondarsi su diversi principi tra i quali: il finalismo rieducativo e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; la personalità della responsabilità penale e la ragionevolezza della pena, sottolineando come un sistema fondato solo sulla intimidazione generale, produca effetti di astio o addirittura di strumentalizzazione del reo, infliggendogli pene eccessive al fine di trattenere i consociati dal commettere a loro volta reati. Bisogna offrire al condannato la possibilità di orientare la propria esistenza nel rispetto di quella altrui e secondo le regole fondamentali della convivenza civile. La pena non è una vendetta, infatti è lecito ritenere che solo orientandosi verso la rieducazione e la risocializzazione del reo si possa aspirare al debellamento della recidiva, così usuale nel nostro paese.
La situazione è ben diversa nei confronti di coloro che, invece, il regime carcerario debbono scontarlo, secondo quanto statuito dall’Art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, comunemente conosciuto ai più come “regime di carcere duro” . Con tale norma si è attribuito al Ministro della Giustizia di sospendere l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati previste dalla stessa legge, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di ordine e di sicurezza pubblica nei confronti di detenuti internati per reati quali criminalità organizzata, terrorismo ed eversione. Tali restrizioni consisterebbero nel rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, limitazione della permanenza all’aperto e la censura della corrispondenza. Su tali restrizioni diverse sono state le questioni di legittimità costituzionale sollevate, tutte rigettate dalla Corte Costituzionale, con le sentenze interpretative n. 349/93; n. 410/93; n. 351/96 e n. 376/97. Tali sentenze hanno confermato l’attribuzione, al Ministro, del diritto di apporre tali restrizioni, a condizione di poterle giustificare e succintamente motivare, in nome della permanenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ne costituiscono il loro presupposto. L’aspetto più problematico a tal punto è l’oggetto della restrizione, la quale, ovviamente, non potrà ricadere su quelle regole che sono alla base dei diritti fondamentali della persona o che attengono al soddisfacimento di bisogni primari quali l’igiene, il vitto; quello a cui si punta è di incidere sulla vita interna all’istituto, ma in primis dei contatti del reo con il mondo esterno.
E’ credenza dei più ritenere giuste le condizioni disumane in cui il reo deve scontare la sua pena, qualunque essa sia; l’espressione “è giusto, deve pagare per quanto ha fatto” dilaga tra la popolazione che non prova vergogna per le atrocità, per lo stato disumano, per la violazione dei diritti che i detenuti ogni giorno, per tutto il tempo della loro detenzione devono subire. La forma mentis è qualcosa che in primis dovrebbe mutare: bisognerebbe puntare ad una società che, conscia dei suoi limiti, miri a costruire un futuro dignitoso per tutti, garantendo anche una seconda possibilità a chi, dopo aver “sbagliato”, se ne sia pentito. Quello a cui si auspica è di ottenere un sistema penitenziario giusto, proporzionato al reato e capace di guardare oltre la pena. Capace di guardare all’uomo, all’individuo colpevole che può cambiare, può essere rieducato, può reinserirsi nella società dopo aver “pagato” per quanto compiuto. Si auspica ad un’evoluzione della giustizia che miri non a punire semplicemente, ma ad ottenere, con il tempo, una società che rispetti la regola o le sanzioni dovute alla sua violazione, in prospettiva di una risocializzazione fiduciosa, che rispecchi i parametri di dignità umana garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.
Infine, già nell’Antica Grecia, Eschilo, nella sua opera l’Orestea, trilogia formata dalle tragedie Agamennone, Coefore, Le Eumenidi, affronta il tema del necessario tramonto della vendetta in virtù del trionfo della giustizia.
Il motivo fondamentale dell’opera è infatti la vendetta, come forma arcaica di risoluzione delle controversie, contrapposta nella terza tragedia al mondo moderno, capace, invece, di organizzare processi che possano fare giustizia. Utilizzando la legge del taglione, un omicidio non può che portare ad un nuovo omicidio, il quale a sua volta dovrà essere vendicato tramite un terzo omicidio. Il meccanismo della vendetta non è dunque più idoneo, ed è necessario che intervenga la comunità a punire i colpevoli. Solo tramite questo intervento, infatti, un crimine potrà essere sanzionato senza generare una nuova vendetta. Nasce quindi la δίκη, la giustizia.
Giustizia che nella prima tragedia coincide con le azioni di Clitennestra, che si fa giustizia da sola per i torti subiti. L’astuzia, la ferocia e l’odio della moglie di Agamennone dominano la prima tragedia, al punto che anche Egisto non è che un burattino nelle sue mani. Nella seconda opera ad Oreste si pongono due alternative, entrambe dolorose e sconvolgenti: uccidere la propria madre, oppure non farlo, macchiandosi così di grave mancanza verso il padre e verso il dio Apollo che gli ha dato l’ordine. Oreste qui fatica ad individuare cosa sia giusto, e infatti la sua vendetta non è priva di esitazioni e rimorsi. Infine nella terza tragedia, grazie all’intervento degli dei s’instaura un processo, che rappresenta il modo corretto e moderno di affrontare le controversie. Eschilo unisce la giustizia umana e quella divina, infatti il processo ad Oreste è celebrato da divinità, ma nell’ambito di un’istituzione, il tribunale ateniese dell’Areopago, che è umana. Gli dei, insomma, intervenendo in quel tribunale danno il loro avallo al moderno senso di giustizia degli uomini e soprattutto degli ateniesi. E, tuttavia, è da notare come la votazione finale della giuria, formata non da divinità ma da uomini, sia di parità, e solo grazie al voto favorevole di Atena, Oreste venga assolto. Eschilo sembra qui voler rimarcare come gli umani siano comunque inadatti a giudicare le questioni divine: se un dio, Apollo, ha convinto Oreste a compiere un’azione sacrilega, solo un altro dio, Atena, può redimerlo.
« Udite ora questo mio decreto, o popolo dell’Attica, nel momento in cui emettete la prima sentenza per il sangue versato. Anche negli anni a venire resterà per sempre al popolo di Egeo questo consesso di giudici. E questo colle di Ares, sede e campo delle Amazzoni, quando giunsero armate per odio contro Teseo, e in quel tempo contrapposero alla cittadella questa nuova cittadella munita di alte torri, e facevano sacrifici ad Ares, donde ha ricevuto il proprio nome questa rupe e colle di Ares– in esso la reverenza dei cittadini e la paura, sua consanguinea, li tratterranno, di giorno e di notte in egual modo, dal commettere ingiustizia, purché gli stessi cittadini non innovino le leggi: se contamini dell’acqua limpida con torbide correnti e fango, non la troverai mai più bevibile. Ciò che non è né privo di comando né sottoposto a dispotismo, questo io consiglio ai cittadini di curare e riverire, e di non espellere dalla città tutto ciò che è pauroso: chi degli uomini infatti è giusto se nulla teme? Se voi rispetterete secondo giustizia questo venerando istituto, disporrete di un baluardo che salva il territorio e la città, quale nessuna gente umana possiede, né tra gli Sciti né nelle terre di Pelope. Incorruttibile al lucro, degno di reverenza, inflessibile d’animo, vigile scolta del paese a difesa di chi dorma: questo è il consesso che io istituisco. Tale lunga parentesi ho pronunciato ai miei cittadini per l’avvenire. Ma ora è necessario alzarsi a deporre il voto e definire questa causa, rispettando il giuramento. E quanto ho detto basti».
Eschilo, Eumenidi, vv. 681-710
Non vendetta, ma giustizia sempre ed a ogni costo!