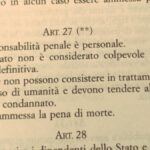Se almeno una volta nella vita avete assistito alla messa in scena di “Dignità autonome di prostituzione”, vi siete ritrovati catapultati in un’immaginifica dimensione della quale non si può più fare a meno, una volta esplorata. Qualcuno era solito affermare che solo dal caos può partorire una stella danzante. La sensazione che si avverte innanzi alla proiezione di questa sublime opera d’arte è proprio questa: una folgore di stelle danzanti, tutte detentrici di superba disperazione ed impellente allegria, pronte a sedurti, ad ammaliarti, per lasciarti di stucco con la loro pillola d’arte.
E se le stelle danzanti le scorgi lontane anni luce, in questo magnifico mondo surreale, le tocchi con mano, ti lasci risucchiare nel vortice della loro incalzante – e commovente – umanità, vorresti stare ad ascoltare i loro monologhi ore ed ore a dispetto del tempo ladro, vorresti volteggiare con loro in quel tripudio di colori, emozioni, canzoni, vorresti spendere tutti i dollarini che hai, pur di arraffare la forma più bella e vivida dell’arte.
Perché si sa, il teatro è capace di possederti, di non lasciarti più andare, di trattenerti tra le viscere di un meraviglioso tormento, innescando in te una terribile catarsi che, se all’inizio ti atterrisce, alla fine diventa la tua ancora di salvezza: questo è “Dignità” e questo è il racconto da parte del suo fondatore, Luciano Melchionna.

D: L’opera nasce dalla penna di Betta Ciancini e di Luciano Melchionna ben 16 anni orsono ed è intrisa di tematiche scottanti e controverse. C’erano talune di queste stesse tematiche che 16 anni fa non potevano essere messe in scena ed ora sì? Com’è cambiato nel corso di quest’intervallo di tempo l’approccio del pubblico rispetto all’opera stessa?
R: “Dignità autonome di prostituzione” è tutto il mio mondo, il mio cuore pulsante, le mie viscere buttate in pasto al pubblico che amo profondamente e a cui sono profondamente devoto. Ogni cambiamento che ha riguardato “Dignità” è un’evoluzione che è avvenuta in me, nella mia persona – e non lo dico per presunzione, ma perché è la verità assoluta.
La figura che forse, più di tutte, ha dato inizio all’opera è Nella.
Nella è una prostituta: non importa quale sia il suo genere, importa il rapporto controverso che ha instaurato con suo nipote – questo stesso nipote che fa i conti con questa “terribile” scoperta, in un primo momento pervaso dal moralismo; solo dopo si rende conto di aver avuto una delle nonne più belle, in grado di insegnare l’amore, la libertà, l’onestà ecc. E da qui scaturisce una profonda riflessione sulla coercizione: ovvero sul fatto che si può essere prostitute perché si è costrette come la nonna, oppure si può scegliere in qualche modo di donare il proprio corpo, in piena libertà.
E in un altro senso, invece, la situazione, rispetto a 16 anni fa, non è cambiata, forse è addirittura peggiorata: mi riferisco al teatro, che ha sempre versato in condizioni abbastanza difficili, drammatiche in questo Paese, come è accaduto, in generale, per la cultura. Spesso è risultato molto complicato lavorare con altri artisti, mancando investimenti sufficienti. “Dignità”, in questo senso, si è configurata come un’occasione per collaborare con più artisti possibili, accomunati da un unico fil rouge: un talento pazzesco. Con Betta Ciancini abbiamo deciso di mettere in piedi una casa chiusa e protetta, in cui tutelarli, visto che lo Stato li lascia per strada. È forse questa la provocazione che permane nel tempo: il desiderio di mostrare al pubblico il valore dei talenti che abbiamo e l’esigenza di restituire loro la dignità – per l’appunto – che meritano.
D: L’opera trasmette allo spettatore un totale, immenso senso di libertà, come se si fosse in assenza di qualsivoglia limite, regola, inutile imposizione sociale. Nella stesura di essa vi sono stati limiti stringenti a cui attenersi o ha dominato la libertà?
R: I limiti ci sono sempre e sono dettati dal senso di responsabilità. Il limite forse più stringente tra tutti è che la provocazione non deve mai essere gratuita o fine a se stessa, ma arrivare ad un pubblico veramente eterogeneo, come quello di “Dignità”, stanandolo. C’è chi continua a ripetere di osare di più, di mettere in scena nudità, sesso dal vivo, di far dire ai protagonisti cose terrificanti: se tutto ciò dovesse essere impellentemente necessario, se dovesse servire a risvegliare le coscienze, se avesse un’urgenza profonda, allora ben venga; ma senza un fine ultimo, no. E questo perché il teatro è sì specchio della vita, ma è anche una grande opportunità per filtrare, trasporre, affinché permetta una catarsi, un collettivo rigenerarsi.
D: L’opera esorta il pubblico a non smarrire il senso di umanità di cui è dotato. In questi 16 anni, il senso di umanità è mai stato smarrito o, al contrario, è cresciuto? Qual è stato il cambiamento che ha percorso il pubblico, sotto questo specifico aspetto?
R: Credo che l’elemento fondamentale che forse, nel pubblico, non è mai cambiato sia l’urgenza di venire in un teatro in cui ci sia sì umanità, ma soprattutto magia, stupore, di essere accolti in un teatro che non sia punitivo. Oggi la maggior parte degli spettacoli costringe il pubblico a subire, ad ascoltare passivamente, mentre è incastrato dentro quelle sedioline. Personalmente credo che questo modo di fare allontani le persone, in particolare, i giovani e, quindi, l’unico modo per arrivare ad ogni strato sociale, coinvolgendo tutti, è proprio l’umanità stessa.
D: A tal riguardo, c’è stata un’evoluzione dopo il Covid-19?
R: Da parte del pubblico ho notato la mia stessa necessità: la dedizione all’amore nell’aspetto più profondo. Non ci si vergogna più di dimostrare l’amore, di averne bisogno: il pubblico è sempre più innamorato, sempre più disposto, mentre prima si tendeva a negare l’importanza di questo sentimento, lo si banalizzava. E alla domanda che tutti mi ponevano durante il lockdown – “cosa stai facendo? Cosa stai producendo?” – ho risposto con un mono-luogo, forse emblema di questo urticante periodo, che s’intitola “senza produrre nient’altro che amore”. Perché si tratta dell’amore che, in questo tempo, mi è stato donato: mi commuove quando le persone mi fermano per strada, dicendomi “non smettere mai”. Un tempo si temeva addirittura di definirsi “artista”: io ho sofferto tanto, in alcuni momenti, ancora oggi, mi interrogo su che senso abbia quello che faccio. Poi quando vai in scena e ti rispondono migliaia di spettatori con un sorriso, con una carezza, con una parola bella, allora capisci che forse ne vale veramente ed assolutamente la pena.
D: Qualcuno sostiene che ogni opera d’arte sia, prima di tutto, un prepotente atto politico. Quanto di politico c’è in “Dignità”?
R: Il teatro dev’essere, in quanto tale, politico: è la sua essenza, la sua ragion d’essere. Questo perché non si può prescindere dal contesto in cui si vive, dalla violenza continua di cui si è vittime tutti. Non è certamente un caso che in “Dignità” ci sia una strenua difesa dei diritti sociali, una difesa che appare assoluta, senza se e senza ma, accompagnata da un’altrettanto stringente condanna della violenza, che culmina nel desiderio di pace.
Nel mio secondo libro, che s’intitola “Mi sfugge di volare – monoluoghi, vol. II”, compare il personaggio del “Senza tutela”, laddove “senza tutela” non significa senza lavoro, ma “con lavoro, senza tutela”: comincia così questo monologo, fino a giungere all’interrogativo “come si può subire in silenzio tutto questo? Come possiamo rassegnarci, assuefarci? Come abbiamo potuto lasciare andare?”. Ed è questa la domanda che, più di tutte, mi spaventa. Però poi, innanzi a migliaia di persone che ti applaudono, c’è da essere ottimisti, perché significa che si stanno risvegliando le coscienze.
A volte sono accusato di essere fin troppo pessimista, soprattutto per i monologhi duri che scrivo. Eppure io mi definisco ottimista, perché sono fermamente convinto del fatto che il vero pessimista è colui cancella la realtà e se la racconta diversamente; per essere ottimista, al contrario, tu devi guardarla in faccia e poter coltivare la speranza che cambi, poter fare qualcosa per cambiare. Questo è il senso di “Dignità”.
D: Come lo si immagina il futuro dell’opera? Ci sono dei cambiamenti che vanno apportati o meno?
R: Io non lo so, non l’ho mai saputo come sarebbe stato l’anno dopo. Ho l’abitudine di cambiare tutto ogni anno che passa: questo perché scocca la scintilla, mi scatta qualcosa dentro, sento il freddo che mi pervade. E solo a quel punto capisco che proprio quello è il futuro di “Dignità”, che si può raggiungere solo e soltanto in un modo: passando attraverso l’inferno.
D: Ogni spettatore si identifica con una particolare pillola d’arte recitata magistralmente da ogni prostituta. C’è una in cui, più delle altre, si rispecchia Luciano Melchionna?
R: Io sono ovunque, c’è un pezzetto di me ovunque: sono in Tsunami, Senza produrre nient’altro che amore, ecc. Ma se proprio dovessi individuare una sola figura in cui rispecchiarmi, senza ombra di dubbio, è “Il sensibile” nella misura in cui non è altro che un modo per raccontare la diversità. Perché la diversità sta anche nel sentire in maniera così forte, nel preoccuparsi, nell’empatia assoluta: a volte, può rivelarsi una vera condanna, al punto da rinunciare a te stesso, pur di sentirti utile a chi ha bisogno di te.

Lo diceva Orson Welles, “il teatro resiste come un divino anacronismo”. E “Dignità” è tangibile espressione di questo splendido anacronismo, superlativo fiore all’occhiello dell’arte teatrale che, seppur agonizzante, conserva sempre intatto il suo potere di riflettere l’animo umano, nei suoi più imperdonabili difetti, nelle sue più smaniose passioni, nella vita pulsante sotto le viscere.